La crisi pandemica determinata dalla diffusione del Covid-19 nel mondo ha, tra le altre cose, dischiuso un orizzonte di possibilità riguardo il processo di cambiamento delle organizzazioni, ponendo le basi per una riconfigurazione senza precedenti dei tempi e degli spazi di lavoro. Due aspetti sembrano emergere in questa tendenza. Il primo è che il lavoro da remoto potrebbe non essere più un fenomeno riguardante una nicchia circoscritta di lavoratori, tra cui i cosiddetti ‘nomadi digitali’ e i lavoratori delle imprese maggiormente coinvolte nelle politiche di conciliazione vita privata-vita professionale e/o più innovative. Il secondo aspetto è che il lavoro da remoto, strumento disegnato come temporaneo e subordinato alla volontarietà dei soggetti della prestazione, potrebbe trasformarsi in una modalità di lavoro permanente o semi-permanente che bilancia esigenze diverse. È del tutto evidente che esso non possa essere confacente a tutti i lavori e a tutte le organizzazioni – si pensi ad esempio al lavoro infermieristico, a quello legato alla logistica o si pensi alle fabbriche. È altrettanto evidente, tuttavia, che il lavoro da remoto potrebbe stimolare l’adozione di modelli organizzativi ibridi che lo alternano con quello in presenza e che contemplano la possibilità per taluni di lavorare dalle loro aree di origine.
In seno a questa possibile e diffusa trasformazione dei modelli organizzativi, si generano notevoli implicazioni per i lavoratori, per le organizzazioni e per i territori. Da un lato, tali implicazioni permettono di ragionare diversamente dinanzi a classici dilemmi del tipo “Do People Follow Jobs or do Jobs Follow People?”; dall’altro, esse pongono interrogativi importanti: per esempio, come cambia la conciliazione vita-lavoro da remoto per lavoratori e lavoratrici? Quanto remoto può essere il lavoro da remoto per un lavoratore di un’azienda del Nord che decide di risiedere al Sud ma che deve recarsi sul posto di lavoro per alcuni giorni al mese? Si pone più sostanzialmente il tema delle disuguaglianze – es. tra i dipendenti della pubblica amministrazione, richiamati in presenza, e quelli di molte aziende creative o altamente tecnologiche per cui il lavoro da remoto è un’opzione concreta -, così come tra territori, che possono entrare in competizione tra loro per attrarre i south worker, anche mettendo le esigenze di questi ultimi davanti a quelle di coloro che, in quel territorio, vivono stabilmente e spesso ai margini.

Le istituzioni vengono, allora, chiamate in causa: insieme all’organizzazione, esse concorrono a influenzare la politica della produzione sotto forma di regolazione. Quest’ultima può giocare un ruolo cruciale per far sì che nuove forme di spazialità del lavoro non diventino fonte di nuove disuguaglianze e, nel South Working, la regolazione può persino contare su un più ampio spettro di attori. Nel caso qui considerato, la regolazione non solo richiama l’azione degli attori tradizionali come lo Stato, l’impresa e il sindacato, ma tende a sollecitare istituzioni locali e regionali, insieme ad organizzazioni del Terzo Settore o gruppi informali della società civile: così come sembra potersi ampliare il luogo di lavoro, superando i confini della impresa/organizzazione, così la regolazione assume natura più territoriale.
A sua volta, la logica della regolazione territoriale solleva quesiti importanti dalla prospettiva del policy making, aprendo alla possibilità di generare benefici condivisi proprio facendo sì che il south working diventi un fenomeno capace di mitigare i rischi legati ad un aumento delle disuguaglianze. Aspetti cruciali attengono alla pluralità degli attori coinvolti, ai diversi livelli in cui si definiscono e implementano le politiche, alla loro natura. Si accenna qui solo ad alcune di queste questioni. Riguardo agli attori, si è già discusso, accanto ad imprenditori e sindacati, si fa più rilevante il ruolo di cittadini singoli o organizzati all’interno di associazioni, di cooperative di comunità o di altri enti del Terzo Settore. Vi è poi la questione dell’integrazione delle politiche in particolare tra politiche del lavoro e quelle territoriali: se le politiche del lavoro vengono spesso associate a interventi quali quelli contro la povertà, raramente esse si integrano con politiche di tipo abitativo, culturale o persino industriale. Questo appare incomprensibile dato che, ancora oggi, nonostante tutti i provvedimenti che lo hanno depotenziato, il lavoro è considerato come uno dei principali fattori di identità e di integrazione sociale. Eppure, in alcuni territori che definiremmo “marginali” a prescindere dalla loro collocazione geografica, l’incrocio virtuoso tra politiche del lavoro e quelle territoriali può diventare efficace per trattenere, attrarre o riattrarre capitale umano, così come per incrementare il benessere multi-dimensionale di tutti i suoi abitanti, specialmente dinanzi alla tendenza diffusa della politica urbana di preferire obiettivi di sviluppo economico alle tradizionali priorità redistributive e sociali.
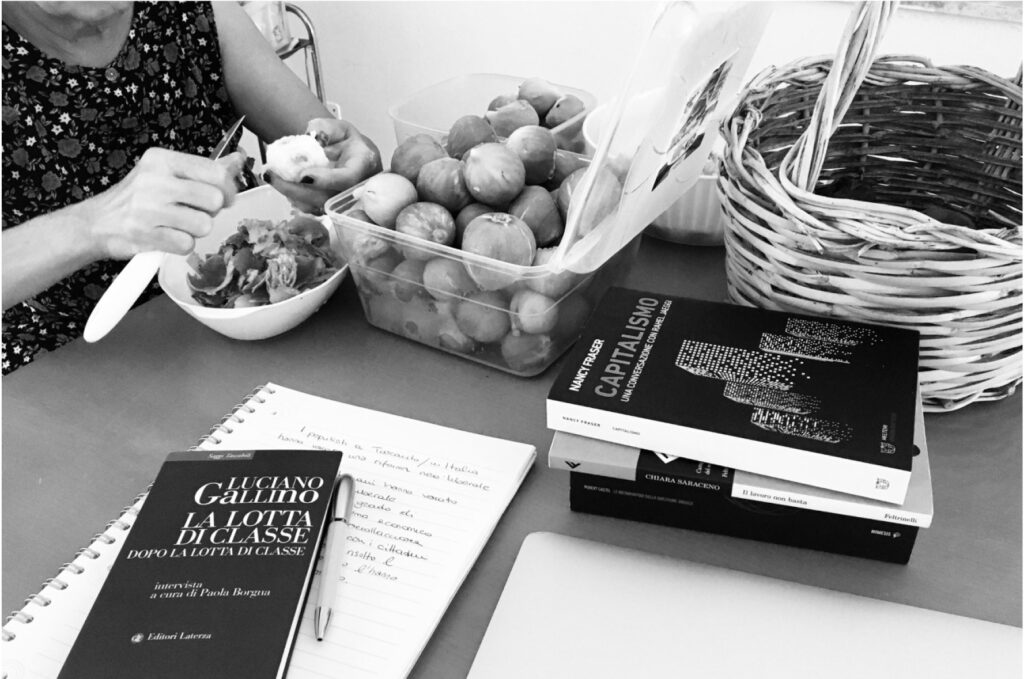
Proprio nei territori marginali, anzi, il South Working può diventare una leva di sviluppo locale significativa per un benessere condiviso tra south worker e gli altri abitanti. Ad esempio, l’integrazione tra politiche del lavoro e politiche abitative flessibili che permettano di accedere a soluzioni di co-housing anche in caso di lavoro da remoto o part-time può portare benefici più ampi laddove esse contribuiscono ad arginare il fenomeno della gentrification. Politiche aziendali che incrementano il benessere lavorativo, tramite per esempio strategie di employee experience (es. dipendenti che diventano partner dell’azienda), e welfare aziendale possono a loro volta integrarsi con politiche sociali che garantiscono ad altri lavoratori una maggiore conciliazione tra tempi di vita e lavoro grazie a nidi comunali e aziendali condivisi, ovvero che garantiscono ai non-lavoratori una migliore fruizione dei servizi socio-educativi per i propri figli attraverso percorsi di istruzione e formazione comuni. In maniera non alternativa ma complementare, le politiche industriali volte alla creazione di nuovi posti di lavoro non possono dissociarsi dalle politiche per l’innovazione o da quelle infrastrutturali. Con queste ultime non ci si riferisce solo alle infrastrutture fisiche e digitali ma anche a quelle sociali, in cui generare e preservare beni collettivi locali. La creazione di spazi comuni per lavorare- il riferimento è al coworking – può essere al contempo concepita come un presidio di comunità; le biblioteche che fungono da poli multifunzionali possono, infatti, evitare il senso di isolamento del lavoro da remoto e contribuire a creare valore aggiunto, tangibile e intangibile per lavoratori, aziende e abitanti del territorio. Infine, ancora a carattere esemplificativo, le politiche giovanili che puntano a creare nuove imprese per rispondere ai bisogni sociali espressi dai south worker, come l’intrattenimento, possono combinarsi con quelle culturali ed anche interculturali, considerata la possibile presenza sui territori di lavoratori stranieri e relative famiglie, che lì giungono per lavorare da remoto oppure che lì già risiedono per altri motivi.
Ulteriori approfondimenti
Greco L., Cacciapaglia M. (2022), Flessibilità geografica del lavoro e politica della produzione:
il South working e il ruolo della regolazione, in in Mirabile M., Militello E., a cura di, South Working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia, Donzelli Editore, pp.33-38.


