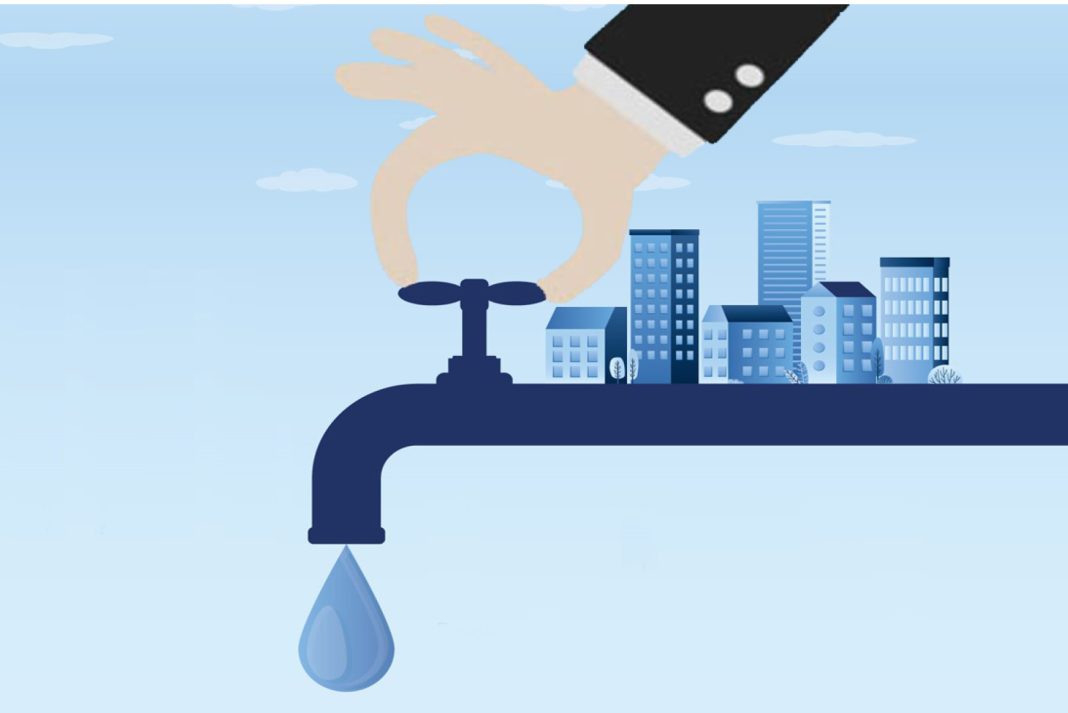Nella governance che caratterizza il servizio idrico integrato (SII) in Italia intervengono più soggetti, ognuno con specifici compiti di regolazione e controllo del servizio. In particolare, a livello locale sono previsti gli Enti di Governo d’Ambito (EGA) partecipati dai Comuni che organizzano il servizio, decidono in merito alla forma, all’affidamento, al controllo della gestione e alla determinazione delle tariffe per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Sia gli EGA che la perimetrazione degli ATO sono indicati dalle Regioni.
Il riassetto della governance del SII va avanti da oltre 25 anni e in alcune aree presenta ancora non poche criticità. Il Blue Book 2022 della Fondazione Utilitatis fornisce un quadro esauriente della frammentazione strutturale e gestionale del comparto idrico: su un campione di 231 società, oltre il 50% ha un fatturato inferiore ai 10 milioni, per appena il 4% del fatturato totale del settore. Per contro, le società con ricavi superiori ai 100 milioni sono il 7% del totale ma rappresentano il 53% dell’intero fatturato del campione, sebbene il servizio idrico sia un comparto in cui sono evidenti le economie di scala.
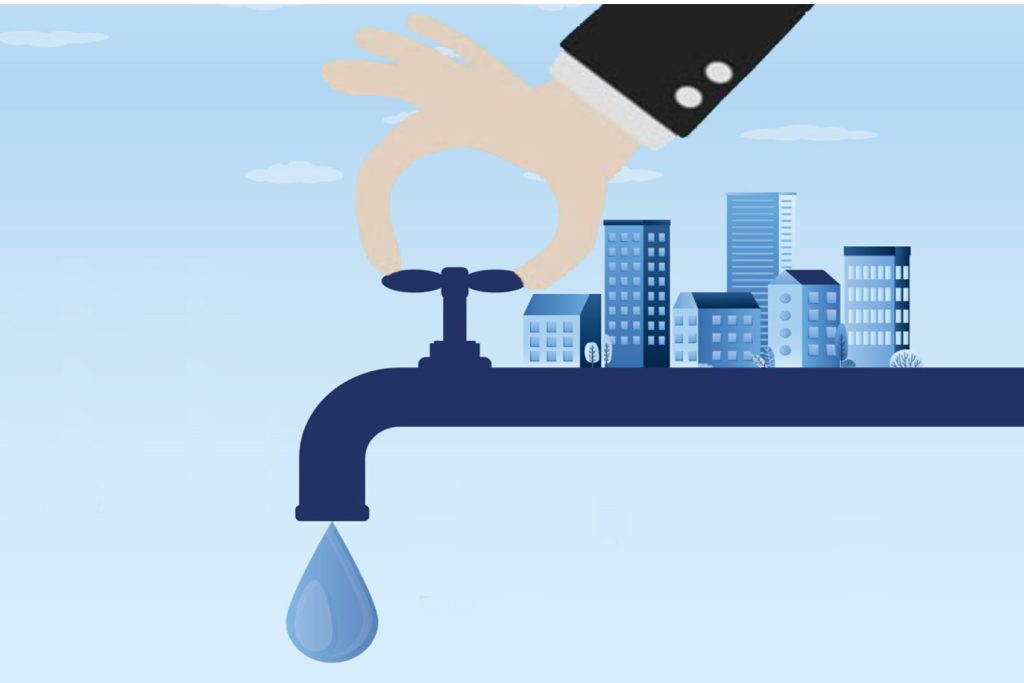
Nel Mezzogiorno, in particolare, le inerzie e le inadempienze delle pubbliche amministrazioni hanno ampliato i divari per quanto concerne la fruizione del servizio a detrimento dell’avvio di gestioni industriali capaci di fornire un servizio adeguato alla cittadinanza, per cui è probabile che sarà difficile accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il processo di razionalizzazione degli ATO è troppo lento, attualmente essi sono 62, rispetto all’esigenza di organizzare il servizio su un ATO unico regionale: ciò porterebbe all’istituzione di un unico EGA preposto all’organizzazione e al controllo del servizio, consentendo di concentrare maggiori competenze rispetto a strutture più polverizzate.
Nonostante l’individuazione formale degli EGA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha segnalato in più occasioni al Parlamento criticità circa la loro effettiva operatività, segnatamente al Sud dove sono operativi solo il 31% del totale contro una percentuale dell’87% nel resto del Paese. Inoltre l’operatività degli EGA è indispensabile per l’organizzazione e la gestione del SII nel territorio di competenza. Se gli atti fondamentali sono la predisposizione e l’aggiornamento del Piano d’Ambito e l’affidamento del servizio al gestore unico, altrettanto importanti sono le funzioni di controllo sull’operato del gestore e di implementazione della regolazione ARERA a livello locale. Ciò comporta il mancato affidamento del servizio al gestore unico: secondo la fondazione Utilitatis la popolazione residente servita effettivamente da un gestore unico d’ambito, potenzialmente in grado di sfruttare economie di scala e di scopo, si attesta a livello nazionale al 57%. Le aree geografiche in cui l’unicità di gestione è stata conseguita sono il Centro Italia (90%), seguito dal Nord Ovest (55%) e dal Mezzogiorno (52%) per il quale è più forte l’esigenza di un processo di razionalizzazione e consolidamento degli assetti gestionali.
Il PNRR può rappresentare un’occasione per il rafforzamento della governance del settore idrico, soprattutto per quelle aree più deboli. In particolare si tratta della Riforma 4.2, denominata “Misure per garantire la piena capacità gestionale peri servizi idrici integrati”, legata all’obiettivo generale M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, che vuole promuovere, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l’industrializzazione del settore, ossia la nascita di operatori del servizio idrico integrati verticalmente e orizzontalmente, con lo scopo di realizzare economie di scala e favorire l’ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti. L’obiettivo, oltre al miglioramento dell’assetto della governance, è dunque la riduzione del water service divide tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese: a livello nazionale, data la vetustà degli impianti, le perdite che si verificano tra il prelievo, l’immissione e la distribuzione nelle reti idriche comunali si aggira intorno al 40% (43% nel Mezzogiorno contro il 36% nel centro-nord).

Con riferimento a tali misure, la razionalizzazione e l’aggregazione dei soggetti gestori è stata infatti prevista dalla Legge di conversione del Decreto-legge 152/2021 sull’attuazione del PNRR, inoltre sono stati anche siglati otto protocolli di intesa tra il MiTE e le Regioni ed EGA in quei territori dove il riassetto della governance è rimasto arretrato: naturalmente tali interventi, per risultare efficaci, richiedono tempi non compatibili con le scadenze utili per l’accesso alle risorse del PNRR.
L’ ARERA ha segnalato al Parlamento nel luglio 2021 una serie di criticità di questi provvedimenti richiamando la necessità di un termine perentorio entro cui perfezionare i processi di affidamento e, in caso di mancato rispetto, la previsione di una gestione transitoria per un periodo di quattro anni (rinnovabili) da parte di un soggetto societario a controllo pubblico con la possibilità di far ricorso a soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie per la fornitura del servizio al fine di garantire l’attuazione degli interventi finanziabili con il PNRR.
Inoltre per l’ARERA è necessario un sostegno tecnico agli EGA, i quali devono essere coadiuvati da un soggetto societario a controllo pubblico in grado di assistere le amministrazioni impegnate nell’organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali. Nei territori in cui non si è ancora instaurato un ente locale di regolazione pienamente operativo, infatti, viene meno anche lo sviluppo di capacità organizzative e di pianificazione necessarie all’effettiva operatività degli enti stessi.
Gli EGA svolgono un ruolo duplice, essenziale, da un lato, per il corretto incanalamento delle risorse europee verso gli interventi previsti e, dall’altro, per un monitoraggio costante dell’attività svolta dai gestori.
Questa funzione è sottolineata dalla Commissione Europea, che individua come elemento critico proprio l’attuale incapacità di controllo locale sulla realizzazione degli investimenti. A tale riguardo risulta evidente – sulla base dei dati del biennio 2018-2019 – che esiste un profondo divario tra le ripartizioni degli investimenti del Centro-Nord e Mezzogiorno: si va dai 49 euro per abitante delle gestioni del Nord Est ai 61,5 euro delle gestioni del Centro, passando per i 56 euro nel Nord Ovest, mentre per il Sud si registra un valore di appena 26 euro di investimenti per ogni abitante.
È altresì chiaro che, pur essendo necessario rispettare le tempistiche dettate dall’agenda del PNRR e che si giunga nel breve periodo alla risoluzione delle criticità, per alcuni territori i ritardi accumulati hanno già precluso l’accesso ai fondi delle prime tranche dei finanziamenti del PNRR. Si pensi al bando pubblicato nel novembre 2021 per le reti idriche relativo alla Linea di azione – Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: 313 milioni di euro destinati alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con un orizzonte di spesa entro il 2023.
Nel bando sono previste specifiche condizionalità volte ad individuare soggetti credibili in grado di attuare gli interventi per i quali si richiedono le risorse da utilizzare nei tempi previsti e impegnati in un percorso di evoluzione della gestione industriale, nel rispetto delle regole. Dato il quadro prima delineato, la capacità di accedere a questi fondi resta problematica e a pagarne le conseguenze saranno i cittadini che continueranno a fruire di un servizio inadeguato.
Nei territori che giungeranno all’affidamento del servizio nei prossimi mesi o che hanno affidato il servizio a gestioni di nuova costituzione sarebbe opportuno un periodo transitorio di affiancamento da parte di soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie. È ragionevole ritenere che i nuovi gestori, soprattutto laddove costituiti per soddisfare i criteri di accesso, potrebbero non disporre delle capacità organizzative e realizzative, necessitando quindi di un supporto esterno da parte di soggetti più strutturati.
Ulteriori approfondimenti
https://www.utilitatis.org/wp-content/uploads/2022/03/BBexecutive_2022.pdf